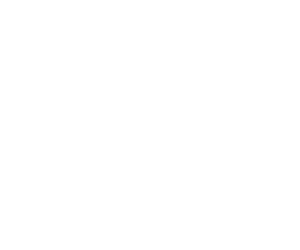Diamanti di Ferzan Özpetek

Diretto da
Starring
Con Diamanti, suo quindicesimo lungometraggio, Ozpetek ci conduce negli anni ’70 all’interno della sartoria Canova, cuore metaforico di un personalissimo omaggio al cinema dove, tra lacrime e taffetà, tesse il ritratto a tinte femminili dell’ombra di sudore e fantasia spesso nascosta dai colori sgargianti del prodotto finito.
Per affrontare quest’impresa, il regista si avvale del miglior universo attoriale femminile attualmente presente in Italia. Alberta e Gabriella Canova, interpretate rispettivamente da Luisa Ranieri e Jasmine Trinca, sono le due sorelle fondatrici della sartoria, antipodali per temperamento. Alberta è pragmatica e inflessibile, resa algida da un amore perso nel tempo (Carmine Recano), mentre Gabriella, ferita da un lutto profondo che condivide col marito (Luca Barbarossa), si mostra fragile, assente e incline all’auto-annullamento. Accanto a loro si muove una variegata galleria di personaggi: Nina (Paola Minaccioni), capo sarta con un figlio hikikomori ante litteram; Eleonora (Lunetta Savino), ricamatrice vedova con una nipote (Aurora Giovinazzo) ribelle e dal precoce talento per il mestiere; Carlotta (Nicole Grimaudo), tingitrice appassionata; Paolina (Anna Ferzetti), madre squattrinata e sola con un figlio che si nasconde nella stanza dei bottoni; Nicoletta (Milena Mancini), vittima di violenza domestica di un brutale marito (Vinicio Marchioni); e Fausta (Geppi Gucciari), single ironica e disinibita. A completare il microcosmo c’è Silvana (Mara Venier), ex ballerina diventata cuoca, pronta a offrire conforto e pasti abbondanti, e Giuseppina (Sara Bosi), stagista che vorrebbe saltare le tappe subito messa in riga dalla matrona Alberta.
La sartoria diventa così un luogo di confessione, confronto e solidarietà, dove le donne si scontrano e si supportano senza mai tradirsi, mentre della Roma di quegli anni, tra contestazione giovanile e drammi sociali, emerge un sussurro sbiadito senza pretese e quasi destinato a sfibrarsi in un’eco per meglio dare quella cornice di alterità spazio-temporale capace di raggiungere l’università della vicenda esistenziale che verte sulla donna. Quando la costumista premio Oscar Bianca Vega (Vanessa Scalera) commissiona i costumi per un ambizioso film di un celebre regista (Stefano Accorsi) ambientato nel ‘700, la sfida professionale si intreccia con le dinamiche personali, creando un racconto che intende celebrare la forza collettiva del genere femminile – la figura del maschio viene infatti rilegata a un contraltare di contorno (il segretario impersonato da Edoardo Purgatori), bersaglio del dileggio e del gioco ammiccante delle protagoniste (i vari figuranti), compagno innocuo (Valerio Morigi, nel ruolo di marito di Nina) o “orchesco” (Marchioni) di una narrazione che se ne serve in maniera deliberatamente superficiale e caricaturale.
Il film, ricalcando l’usuale immaginario del regista fatto di striature sgargianti e malinconiche, si sviluppa in un andamento a spirale, un girotondo in cui le attrici prendono a turno il loro spazio per descrivere le varie sfaccettature del dramma di quell’unico personaggio corale che si ritrovano a incarnare – disgrazia, lotte e sfide personali, familiari, sociali. La narrazione procede con il ritmo mutevole delle sinfonie, con un’estetica raffinata, fatta di colori caldi, luci soffuse e una cura maniacale per i dettagli, in cui la stessa Sartoria, riflesso di questa meticolosità, diviene un personaggio a tutti gli effetti – superbo il comparto costumi e quello musicale che, anche se sottilmente invadente, è impreziosito da due inediti di Mina e Giorgia.
Per quanto il realismo emotivo di Ozpetek riesca a delineare con gran pulizia i rilievi drammatici dei personaggi, sottraendoli con sbalzo d’esperienza a un altrimenti quasi inevitabile marasma, la profondità psicologica non è mai sfiorata con intensità, e il caleidoscopio di luci e ombre in cui siamo proiettati, oscillante tra ragionato sentimento e vulcanica volontà, non riesce a restituire una raffigurazione davvero incisiva sull’esperienza dell’essere donna nella società contemporanea. L’opera del regista turco-italiano appare sovraccarica, un gineceo di cliché sicuramente infusi in un’atmosfera trasognata dal tocco elegante e inconfondibilmente delicato, ma che finisce per appiattire i temi trattati – solo abbozzati e mai approfonditi – e per diluire il potenziale emotivo del film comunque presente, lasciando allo spettatore un’aleggiante sensazione di superficialità. La sceneggiatura alterna infatti momenti di lucida pungenza a scivoloni melodrammatici dal tono un po’ troppo soap opera su tempi a tratti leggermente annacquati, con battute pletoriche, pomposette e spesso abbastanza naif («Siamo niente però siamo tutto») – da segnalare sono i lampi della Gucciari, che, con il suo ardore comico, è capace di scandire e rianimare periodicamente il buio della sala illanguidito dall’ammaliante magia visiva. La costruzione drammaturgica non brilla poi di eccessiva originalità: le dinamiche di sorellanza, tra le due protagoniste e anche quelle più generali di solidarietà femminile, risultano schematiche e prevedibili, così come la meccanica di decostruzione cui vanno incontro i personaggi di Alberta e di Bianca Vega, quest’ultimo intarsiato dal debordante impeto di una più che valida Vanessa Scalera. Anche l’eterno diverbio-divario tra teatro e cinema, qui impersonificati rispettivamente da Carla Signoris e Kasia Smutniak, si livella sullo stereotipo dei due soliti opposti divismi in piccato contrasto, qui almeno ravvivato dalla verve efficace delle due interpreti.
Delle attrici si potrebbe dire di più. Ci accontentiamo di nominarne alcune per illustrare le dinamiche di quanto segnalato più sopra. La Ranieri, per quanto si confermi con questa interpretazione un’icona del nostro cinema, sembra inscatolata in innumerevoli occhiate irrealistiche di un Ozpetek incancrenito su primissimi piani tesi a strappare forse con troppa insistenza ogni emozione dal visibile. Jasmine Trinca, bellissima nel suo candore macchiato da occhiaie più che emblematiche, riesce a trasmettere la tragicità della sua condizione, anche se forse un po’ compressa da una costruzione a fior di pelle che avrebbe potuto esaltarne maggiormente la bravura. Una menzione, oltre alla Gucciari, anche a Nicole Grimaudo e Mara Venier: la prima per il suo estro sognante ed efficiente nella minimalità della parte, la seconda per aver varcato a ritroso le frontiere di Domenica In in un ruolo veritiero e mestamente commovente, per quanto tirato giù da una sceneggiatura come già detto non proprio perfetta – ogni frase sembra voler infatti sottolineare un’emozione già evidente, togliendo spazio alla sottigliezza e alla spontaneità.
Infine, le riflessioni meta-cinematografiche del regista. Durante il film vengono posti degli spezzoni in cui si assiste allo stesso regista dare istruzioni sul film che sarà al cast seduto in tavolata, insieme ad altri in cui egli interpreta sé stesso, come sul finale. Si potrebbe ragionare sulle sue reali intenzioni – moltiplicazione drammatica dei piani narrativi che rompa la finzione di verità: persone che si preparano a fare un film su persone che preparano un film? A che pro, dove la cifra incisiva di una tale mossa in questa resa? Ma a limitarci agli effetti assistiamo a una cornice metanarrativa posticcia, superflua e un po’ patetica, che provoca il depotenziamento dell’estaticità tremolante del film e la rottura d’immedesimazione dello spettatore in maniera fin troppo gratuita. Il finale poi, dove assistiamo al faccione di Ozpetek con tanto di ammiccamento dritto in camera contrapposto alla figura angiolesca e alla voce fuori campo di Elena Sofia Ricci, sembra più un’appendice decoro-dichiarativa che un rafforzamento dello scioglimento interno della narrazione, che ne appare straniata e prolissamente allungata. Sappiamo che il film origina anche dall’esperienza personale del regista come aiutante nella storica sartoria Tirelli; eppure questo finale, organicamente discutibile, rischia di dare adito a una critica di presenzialismo autocelebrativo, narcisista e brandizzato che già soffia sulla sua figura. La figura di sé stesso che prende la sfera di gomma col pesciolino regalata nel film da Silvana al figlio di Paolina immortala senza dubbio il suo debito nei confronti del cinema, giustificando questo omaggio e chiarificando le parole pronunciate dalla Ricci: «Il cuore mescola continuamente cosa è successo con quello che abbiamo solo immaginato, i vivi con i morti, il visibile con l’invisibile, l’amore con il dolore. Quello che siamo va oltre la memoria e la vita. È ciò che rimane quando tutto il resto sparisce. Questa è l’eternità. Questo è il cinema». Tuttavia, il risultato appare forzato e sbrigativo, e viene da chiedersi se quest’intima deduzione non fosse da consegnare all’eternità nel silenzio parlante dell’invisibile, a una scelta di una non-mostrazione fiduciosa dell’azione evocativa del cinema così programmaticamente tentato.
Per concludere, Diamanti possiede tutta la malia visiva e la dolce malinconia cui il regista ci ha abituato, una confezione elegante che però non basta a mascherare le sue fragilità strutturali. È un film a suo modo opulento, strabordante, di sensibilità e personalità – la stessa del regista. Un film che ci fa apprezzare le donne e la loro resilienza intrisa di grazia, senza però farcele assaporare davvero nella loro intima vertigine. C’è spazio per la meraviglia che accompagna il cammino verso la perfezione di un’idea materica – il costume, il Cinema –, l’istinto di chi lotta nel tempo contro il fato e le proprie debolezze, la gioia di farcela e anche di raccogliere i propri errori insieme. L’impressione è quella di un’armonicità di facciata, con lustri e dissonanze propri di fard e perline, un’orchestrazione sapiente e peculiare del talento attoriale che ha forse, oltre ad autentiche vette nel suo affresco emotivo, anche l’idiosincrasia dalla sua parte per farsi largo nella memoria.
I diamanti non si trovano ovunque. Eppure molti ne cercano, in un riflesso, la propria e personale magia: se è vero che la loro luce è più dura di una menzogna, al tempo l’assenza di forgiarne il bagliore.
Pubblicato il:
Tag:
Consigliati per te
La Prima Festa di Pietro Fuccio segue la lunga gestazione durante la pandemia di Covid-19 della "Prima Festa dell’Amore", il concerto immaginato dal musicista piemontese Cosmo.
Con 'Nouvelle Vague', Richard Linklater ci porta nella Parigi di fine anni '50 per rivivere la rivoluzionaria New Wave che ha scosso la storia del cinema.
Dal 3 all’8 Marzo 2026 torna SEEYOUSOUND, il festival torinese dedicato alla narrazione dell’arte musicale attraverso il dispositivo cinematografico.