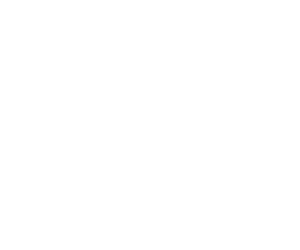The Assessment di Fleur Fortuné

Diretto da
Starring
Mia (Elizabeth Olsen) e Aaryan (Himesh Patel) desiderano un figlio. Lei è una talentuosa botanica, lui un prodigio della programmazione, progettista di animali domestici virtuali. La vicenda di The Assessment si svolge in un futuro distopico in cui l’ambiente è stato sconvolto dai cambiamenti climatici: una parte della popolazione vive protetta dall’invecchiamento grazie a un farmaco promosso da uno Stato pervasivo, mentre nel “vecchio mondo” alcuni superstiti, dissidenti o esiliati, sopravvivono esposti alla radioattività e alle leggi naturali. Gli abitanti del “nuovo mondo”, sottoposti a un rigido controllo sulle nascite, non possono infatti avere figli se non tramite una gestazione extra-utero concessa alle coppie più meritevoli in seguito a una scrupolosa valutazione di sette giorni (che, se fallita, non può essere ritentata). La coppia va allora incontro alla visita dell’enigmatica esaminatrice Virginia (Alicia Vikander). Dopo un’inchiesta preliminare sulle loro storie personali, la convivenza con l’assessor si rivela essere una conflagrazione dell’equilibrio apparentemente perfetto dei due. Virginia, per testarne le attitudini, li sorprende fingendosi una ragazzina intrattabile, mettendoli così di fronte a tutta una serie di situazioni limite che, tra incursioni imbarazzanti nell’intimità e illogici attentati al loro benessere materiale e affettivo, evolvono fino a un claustrofobico parossismo. In un progressivo instaurarsi di un rapporto morboso e ambiguo – «Ora sei tu, Virginia, oppure no?» – la coppia viene portata allo sfinimento, in un clima denso e paranoico dove i confini della professionalità della valutatrice sfumano in un’assurda perversione che ha il retrogusto di un oscuro ed equivoco arbitrio.
Il film segna l’esordio al lungometraggio di Fleur Fortuné con una regia pulita, bilanciata e priva di sbavature, sia nel senso di eccentriche sprezzature che di originali colpi d’autore. La dinamica tra i personaggi, impreziosita da un’evidente ed efficace impostazione teatrale, si sviluppa soprattutto in interno, in una straniante casa fronte oceano arredata in stile anni 70 e ispirata alle geometrie colorate di Mondrian. La colonna sonora accompagna fin da subito la visione in un’atmosfera sinistramente eterea in cui brilla l’interpretazione di una straordinaria Alicia Vikander, vera protagonista della narrazione.
In prima battuta, infatti, un’analisi superficiale della pellicola potrebbe portare al giudizio che la riflessione portante sia focalizzata sulla genitorialità, sullo sconvolgimento climatico e sull’oppressione biopolitica di sorveglianza dell’autorità statale sulla quotidianità, insieme al rapporto di quest’ultima con la tecnologia. É innegabile che la trama visiva servi questi temi per un’immediata immedesimazione; tuttavia, per quanto mostrati nelle loro ricadute esteriori, la sceneggiatura non scava più a fondo, mantenendoli più simili a pretesti per un’operazione concettuale più latente – il rapporto uomo/natura è infatti solo sfiorato e confinato in un altrove spazio/temporale molto nebuloso; l’impatto della tecnica sulla vita è mostrato ma non opportunamente drammatizzato, e l’intuizione più vibrante a riguardo, ovvero la camera delle simulazioni virtuali di Aaryan, rimane poco battuta; lo stesso desiderio nei confronti di un figlio appare quasi più un antefatto concluso, che un complesso aggrovigliato da dipanare dal vivo nelle sue implicazioni esistenziali e sociologiche.
L’operazione in questione ha a che fare con il ruolo di Virginia (seguono spoiler). Nella seconda parte del film, dove l’unità rappresentativa del film si spezza aprendo a una spiegazione sulla sconcertante intensità dell’intrusione di Virginia, apprendiamo che sono sei anni che una coppia non riceve più il benestare per la fecondazione e, nonostante ciò, lo stato non interrompe il processo di assessment. Virginia ha perso un figlio e vive in condizioni misere rispetto al privilegio elitario della sistemazione-rifugio dei due scienziati; il motivo per cui seguita a logorarsi in quel lavoro è la promessa, da parte dello stato, di avere un figlio in futuro. Nella parte finale del film, assistiamo al suo gesto estremo e disperato, in seguito a una domanda da parte dell’ennesima mamma speranzosa che le chiede se lei passi del tempo a contatto con i neonati: un sorriso agrodolce, uno sbuffo che sa di rivelazione, e poi la scelta, la fine. In maniera tacita e tuttavia più penetrante del messaggio esteriore che trapela dalla trama, il film ci pone di fronte all’immane tragicità di colei che si ritrova a incarnare, simulandone così integralmente lo spettro emozionale, l’assenza subita – la prole, di senso e di futuro –, condannata in un eterno presente di giovinezza ad alimentare una falsa speranza come puro meccanismo di riproduzione, in seno alla società, di un significato inalienabile alla natura umana: il dramma dilaniante, ovvero, di chi conosce l’inganno e il sublime segreto esperienziale – la gioia della maternità, mistero supremo – di cui osserva continuamente sia la negazione sia l’anelito. Oltre alle facili e moralistiche interpretazioni nei confronti dell’abuso supposto dello stato e al solletico implicito nello spettatore, quasi naturalmente portato a interrogarsi sul comportamento da adottare per scongiurare un così tristo futuro, una domanda più universale sembra emergere con forza: quanta dose di illusione siamo costretti ad accettare e a riprodurre, fuori e dentro le istituzioni, per garantire la sopravvivenza individuale e collettiva? Quanta menzogna è necessaria per l’esistenza?

Due scene, infine, meritano una particolare attenzione per esaminare le linee di fuga dello script. La prima è il cinico discorso di un’invitata alla cena-test a casa della coppia, una donna di 153 anni che, parlando del mondo prima della catastrofe, sentenzia così: se si vuole essere veramente sostenibili e contribuire al bene della società (la motivazione esplicita di molte coppie nel desiderio di un figlio), bisognerebbe rassegnarsi a rinunciare alla prole. La seconda vede la distruzione della serra di Mia causata da Virginia. Mentre si assiste alla disgregazione del lavoro di una vita (all’interno l’unico ricordo della madre dissidente, un’orchidea), vediamo Aaryan riuscire finalmente a trovare il codice per fornire il giusto senso della tattilità alle sue creazioni virtuali, con cui poi darà alla luce il suo figlio virtuale. Abbiamo così, polarizzati con sottigliezza, i due poli di un mondo della tecnica e dell’artificio che tematizzano lo scontro sul concetto di naturalità. Per dirla con Simmel, la differenza tra l’albero da frutto (il giardino, la serra) e l’albero maestro (l’ingegneria, la stanza): la contrapposizione cioè tra quelle che potremmo definire una “tecnica naturale”, la quale accompagna le forme all’espressione della loro precipua natura, e una “tecnica artificiale”, che interrompe la vita di una forma per piegarla a un fine a lei estrinseco (il tronco reso ausilio per la navigazione). Il finale del film esibisce forse una direzione: a una vita imbevuta dell’odore anonimo di un simulacro, Mia preferisce il confino, l’interzona radioattiva, la luce polverosa in cui la morte e la vita possiedono ancora la dimensione tenebrosa dell’umano, andando a ripercorrere quella che fu la sorte della madre – riallacciandosi così, simbolicamente, a un veicolo di trasmissione del sapere, sotterraneo e incontrollabile, altrimenti esacerbato in una società chiusa di immortali: la filiazione.
The Assessment ha il merito di proporci questa prospettiva di sguardo senza la pressione urticante della propaganda, di un’urgenza culturale. Nonostante l’immaturità stilistica – il film potrebbe essere infatti un’espansa puntata di Black Mirror – riesce a costruire una maglia di vibrante tensione attoriale che, come evidenziato, va oltre il cliché del suo inquadramento tematico. Lo sviluppo narrativo appare piuttosto prevedibile; tuttavia la regista e gli sceneggiatori si guardano bene dall’inserire elementi singolari per il puro gusto dello shock e riescono a tessere un amalgama compositivo intrigante fatto però di rilievi abbozzati e privo di manifesti abissi riflessivi. Un esordio dal sapore minimale e senza graffi, soavemente sconclusionato ma ribollente di un profondo tremore etico.
Pubblicato il:
Tag:
Consigliati per te
La versione di Fennell di "Cime tempestose" trasforma l'amore metafisico del romanzo, in un'immagine poetica del desiderio terreno.
La lista dei film più attesi del 2026 secondo la redazione di Strade Perdute Magazine
Con 'Hamnet' Zhao trasforma il dolore in poesia viva: Shakespeare custodisce suo figlio nell'Amleto, dove la perdita diventa memoria.