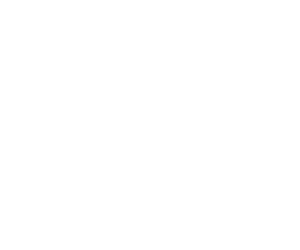Ritratto di un certo Oriente di Marcelo Gomes

Diretto da
Starring
Oscure onde sonore e un elegiaco canto degli uccelli in sottofondo. Una citazione di Milton Hatoum, scrittore dell’omonimo romanzo da cui il film è tratto: «E il passato era come un perseguitatore invisibile, una mano trasparente e seduttiva», che risuona con la gravità di un destino ineluttabile. Un primo piano che indugia su una fotografia sbiadita dal tempo: due adulti e due bambini, presumibilmente genitori e figli, imprigionati in un’istantanea che tradisce la memoria di un’esistenza un tempo felice. Così si apre Ritratto di un certo Oriente, ultima fatica di Marcelo Gomes, che sin dal prologo rivela la tensione latente e il fulcro nevralgico su cui è fondata: la contraddizione, restituita da una struttura lineare costantemente interrotta da brevissimi squarci stilistico-narrativi, impressionanti nella loro forza trattenuta, strazianti nella loro grazia dominante, rivelatori nella loro saggezza storica.
Si distinguono, anzitutto, alcuni brevi ritagli quasi documentaristici di quelle che appaiono come interviste individuali, durante le quali alcune comparse, il cui sguardo è diretto verso la macchina da presa, noncuranti della quarta parete, articolano pensieri e confessioni e disvelano squarci del loro vissuto interiore, contaminato da un flusso inesorabile di eventi storici laceranti, impossibile da evitare. In secondo luogo, affiorano fulminei frammenti estetici, ma non estetizzanti, che si soffermano sui continui cigolii e stridori della nave – con cui Emir (Zakaria Kaakour) ed Emilie (Wafa’a Celine Halawi), fratello e sorella, i due bimbi nella fotografia di inizio film, salpano da Beirut verso il Brasile, sul finire degli anni ’40, per sfuggire alla guerra presente nel loro territorio, e che ben presto si trasforma in un ‘carontesco’ set cinematografico -, sulle formiche che emergono instancabili dal terreno, sugli uccelli che navigano nel cielo: autentici riverberi diegetici delle speranze e delle inquietudini che affliggono i protagonisti, sospesi tra l’addio e l’ignoto. Si giunge poi alla presenza magnetica e ambivalente di Omar (Charbel Kamel), figura al tempo stesso luminosa e perturbante, che incarna un bivio esistenziale per i due fratelli. Per Emilie, un punto da cui ripartire: i due si scambiano sguardi silenziosi, densi di sottintesi, che guidano e smascherano il loro sentimento reciproco che si consuma in una scena amorosa ai limiti del primordiale, in cui il suono viscerale del cibo si mescola con il respiro febbrile dei corpi, un intreccio sensoriale che culmina in un amplesso, a sua volta scandito dall’alternanza formale tra nitidezza e sfocatura della ripresa. Per Emir, al contrario, Omar è un’ombra da estirpare, un’intrusione che mina l’ordine della sua esistenza futura per via del suo desiderio di controllo della sorella e della distanza religiosa che li separa, che s’inaspriscono fino a un pericoloso scontro fisico. Omar è quindi, insieme, uno spiraglio di luce e una tenebra da bandire.
Le opposizioni che hanno attraversato l’intero arco narrativo trovano la propria catarsi e, al contempo, epitome in due sequenze separate da un semplice stacco di montaggio, attraverso cui si dispiega la dialettica visivo-emotiva densa e irriducibile dell’opera. Nella prima, siamo testimoni di una visione angelica del giardino che sorge nella nuova casa di Emilie e Omar, inquadrato nei limiti di una finestra, come fosse un quadro, una tela – un ritratto, suggerirebbe il titolo – di serenità, di speranza, di promesse aperte verso un futuro luminoso. Nella seconda, invece, l’angolazione si rovescia e ci accoglie il silenzio gelido di un campo totale, inizialmente buio, che ritrae Emir, solitario nella sua stanza, osservato attraverso i confini imprecisati di una porta – ancora un’inquadratura nell’inquadratura -, che accende la luce e con un gesto rapido, quasi convulso, si riflette nello specchio e il suo sguardo rivela un pensiero oscuro, che si fa strada nella sua mente e si scolpisce sul suo volto, rivolto al tormentato passato e incapace di accettare il prossimo matrimonio tra l’odiato Omar e l’amata sorella.
La contraddizione è dunque forza predominante nell’opera. Eppure, nella parte conclusiva, quando una serie di fotografie del viaggio, esistenziale, appena percorso regala un sorriso a Emilie e Omar, i conflitti trovano un’oasi di pacificazione, un rifugio di equilibrio, un telaio nel quale potersi distendere e scoprire un senso non di illusorio appagamento, ma di ritrovata consapevolezza: «Non è magia, è semplicemente la scienza» afferma l’esperto di fotografia a bordo della nave mentre mostra a Emir la sua attrezzatura e una foto della sorella. Ebbene, ciò di cui abbiamo bisogno, sembra sussurrarci Ritratto di un certo Oriente, non è magia, ma semplicemente il mondo reale filtrato dalla macchina da presa e da un pensiero artistico, rievocando una sua – dell’arte, non solo cinematografica – sempre più urgente necessità.
Pubblicato il:
Tag:
Consigliati per te
Sirāt si impone come un’opera visivamente potente e capace di incidere sui sensi, ma fatica a tradurre tale impatto in un solido discorso critico.
Park Chan-wook torna a meravigliarci con le divertenti e violente assurdità di 'No Other Choice'.
Strade Perdute esce con un nuovo numero sei dal tema Viaggi!