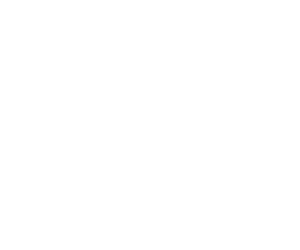Marty Supreme di Josh Safdie

Diretto da
Starring
Marty Supreme esordisce al botteghino italiano preceduto da un’attenzione mediatica imponente. L’anteprima al Torino Film Festival, la risonanza critica internazionale e le numerose candidature agli Oscar ne hanno consolidato lo status di “film evento” ben prima dell’uscita nelle sale. A sostenere questa centralità ha contribuito una campagna promozionale pervasiva, capace di indovinare trovate e immagini virali (come Timothée Chalamet vestito d’arancione per richiamare le palline da ping pong), trasformando il film in un oggetto onnipresente nel discorso pubblico.
Ambientato nel 1952 e liberamente ispirato alla figura reale di Marty Reisman – campione di tennistavolo noto tanto per il talento quanto per il suo istrionismo – il film delinea il ritratto di un outsider eccessivo in un’America ancora segnata dal dopoguerra. Un biopic sportivo atipico, almeno nelle intenzioni, che segna il ritorno alla regia di Josh Safdie, questa volta senza il fratello Benny (impegnato su altri fronti come The Smashing Machine, 2025).
Il primo elemento che colpisce è la dedizione fisica totale di Chalamet. L’attore lavora sul corpo in modo ossessivo, spingendosi in sequenze che sfiorano le riprese da stuntman, specialmente nelle partite, girate con una precisione coreografica e una leggibilità cinetica rara. La sua performance è senza dubbio il motore del film, alimentato da una colonna sonora firmata Oneohtrix Point Never che rifiuta consapevolmente ogni ricostruzione filologica.
Le sonorità elettroniche anni ’80 – tra hardware analogico, beat sequenziati e needle drop di Peter Gabriel, Tears For Fears, New Order e Public Image Ltd.– creano un voluto cortocircuito. Non descrivono l’ambientazione anni Cinquanta, ma la reinterpretano in chiave mitologica, cercando un impatto emotivo più che la fedeltà storica. Anche la ricostruzione visiva, tra costumi e scenografie, segue questa visione, restituendo un’epoca riconoscibile sul piano estetico.
Oltre Chalamet, anche il cast di contorno aveva contribuito a generare alte aspettative: Gwyneth Paltrow appare ironicamente calata nei panni di una diva in declino, una scelta che sembra giocare consapevolmente con la sua stessa immagine pubblica, mentre Tyler, the Creator esordisce con carisma sul grande schermo. Tutti gli attori forniscono interpretazioni solide, ma vengono progressivamente sacrificati da una scrittura che non concede loro autonomia.
È qui che Marty Supreme inizia a mostrare le sue crepe più strutturali. L’energia che attraversa il film non si traduce mai in una vera costruzione narrativa. La regia si ancora a un’estetica esasperata – macchina a mano, montaggio aggressivo, primi piani iperdettagliati e rapidissimi – generando una sequenza continua di “raptus estatici” che rifiuta qualsiasi modulazione del ritmo. Tutto è frenetico, sempre: una scelta che finisce per appiattire ogni momento sullo stesso registro, dove il movimento sostituisce il racconto e la confusione prende il posto dell’intensità.
La centralità assoluta del protagonista diventa così un gabbia. Lo sguardo resta troppo incollato a Marty, relegando il destino e la funzione degli altri personaggi al fuori campo. L’ambiguità morale di Marty, inoltre, risente della mancanza di una costruzione drammatica tangibile. Se in Filth (Jon S. Baird, 2013) il poliziotto corrotto di James McAvoy risultava magnetico in quanto le sue azioni impattavano su un mondo vivo e tangibile, qui la distruttività di Chalamet resta sospesa, priva di attrito. Non scandalizza, non affascina, semplicemente scorre.
Come già detto, a farne le spese sono i comprimari. Rachel Mizler (Odessa A’zion) – amica di infanzia invaghita del protagonista – dovrebbe fungere da contrappeso affettivo, ma agisce spinta più da necessità di trama che da una reale evoluzione psicologica. Dion Galanis (Luke Manley) e Wally (Tyler Oknoma) sembrano solo presenze riempitivo, personaggi funzionali e privi di tridimensionalità. Persino la scelta di scritturare Abel Ferrara, curiosa e potenzialmente carica di senso cinefilo, rimane poco più di un cameo, con un ruolo sviluppato in maniera tutt’altro che chiara.
In questo quadro, le sequenze di ping pong restano l’elemento migliore: fisiche, leggibili, spettacolari. Eppure, lo sport viene relegato a semplice sfondo, utilizzato come giustificazione per gli spostamenti del protagonista, senza mai farsi vero motore drammatico. Il confronto con Challengers (Guadagnino, 2024) è contemporaneamente illuminante e impietoso: lì lo sport veniva promosso a sfondo. Il tennis era integrato nel racconto al punto che la trama si chiariva durante le partite stesse; qui resta un intermezzo visivo, efficace ma isolato.
Le uniche figure che sembrano cogliere davvero la natura di Marty sono Endo (Koto Kawaguchi), il campione giapponese che lo affronta dentro e fuori dal campo, e i suoi tifosi; agli occhi del pubblico nipponico Marty non è un antieroe, ma un antagonista puro: sbruffone, iroso, invasivo. Il suo rivale, segnato dalla sordità in conseguenza della guerra, rappresenta un potente specchio morale che avrebbe potuto trasformarsi nel suo contraltare tragico. Il personaggio di Endo, però, rimane sfumato: il suo trauma viene evocato, mai raccontato. Resta un dettaglio, non una storia.
Lo stesso vale per gran parte delle sottotrame. Episodi come il flashback della prigionia di Béla Kletzki (Géza Röhrig) nei campi di concentramento o il lutto di Milton Rockwell (Kevin O’Leary), sembrano inseriti più per certificare l’ambientazione che per nutrire il racconto. Appaiano come frammenti isolati, quasi parentesi didascaliche utile a ricordare allo spettatore il contesto storico, senza però avere reali conseguenze narrative. Sono informazioni che spiegano, ma non costruiscono. La Storia viene citata per accumulo (telefoni a rotella, accenni biografici e traumi), ma non è integrata: i personaggi sembrano figure contemporanee calate in una scenografia d’epoca.
Paradossalmente, gli elementi che dovrebbero sostenere Marty Supreme si trasformano nei suoi limiti più evidenti. L’antieroe non diventa mai davvero magnetico, la velocità genera stanchezza anziché tensione e il ricco cast finisce inutilizzato. Alla fine, restano una prova fisica impressionante e un’agitazione costante: troppo poco per trasformare la corsa in un vero percorso.
Pubblicato il:
Tag:
Consigliati per te
La lista dei film più attesi del 2026 secondo la redazione di Strade Perdute Magazine
Con 'Hamnet' Zhao trasforma il dolore in poesia viva: Shakespeare custodisce suo figlio nell'Amleto, dove la perdita diventa memoria.
Josh Safdie firma un biopic sportivo elettrico con un Timothée Chalamet totalizzante. "Marty Supreme" non sta mai fermo. Nemmeno quando servirebbe.