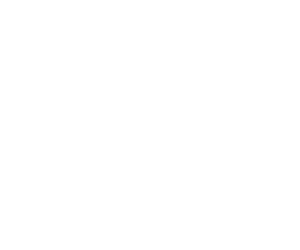Hokage – Ombra di fuoco di Shin’ya Tsukamoto

Diretto da
Starring
Hokage – Ombra di fuoco (2023) chiude la trilogia di Shin’ya Tsukamoto dedicata all’implosione della psiche come conseguenza dell’eredità mortifera e distruttiva della guerra. In continuità con Nobi-Fires on The Plain (2014) sulla deflagrazione della carne nella guerra, o di Zan-Killing (2018) sullo strascico dell’omicidio attorno a una spirale etica, Hokage indaga il riverbero sottocutaneo di tali scenari: un requiem sussurrato da chi è sopravvissuto troppo a lungo in un limbo di sospensione della natura umana di fronte alla violenza. Il film segue il vagare di un bambino dall’indole curiosa e osservatrice (Oga Tsukao) intento a sopravvivere in una Tokyo dilaniata dai fuochi del secondo conflitto mondiale. In uno panorama di totale desolazione, verrà avvicinato da diversi individui spiritualmente spezzati, convinti di poter sfruttare il giovane per ritrovare un’umanità purtroppo spezzata e smarrita.
Tsukamoto prende la fine della guerra e la plasma come un corpo in necrosi, affetto in diverse zone da una decomposizione senza via di ripresa. Il conflitto è uno spettro che filtra da sotto la pelle dei personaggi, dalla ruggine delle case, pronto a infestare i pensieri dei personaggi fino a un loro lento spegnimento vitale. L’universo visivo di Hokage richiama dunque i luoghi più prossimi agli incubi onirici di Nightmare Detective (2006) o Haze (2005), senza tuttavia ricorrere a iperboli o deformazioni grottesche: l’orrore, questa volta, è semplicemente nei colori. Il rosso e l’azzurro saturano ogni inquadratura, impastandosi nella fotografia con una densità tossica.
Il rosso è anzitutto il fuoco che ha consumato vite e case, il sangue di quanti sono morti in battaglia, il grido di rabbia trattenuto negli aloni neri delle abitazioni sopravvissute. L’azzurro è il ghiaccio della malinconia, la depressione che attanaglia ogni gesto, l’incomunicabilità di personaggi afflitti da un mutismo spirituale manifesto in una rete di silenzi. La stanza iniziale del film – spoglia, con una finestra velata di luce blu e un futon che quasi rievoca un altare funebre – è già una dichiarazione di poetica: il trauma non abita più i campi di battaglia, ma gli interni domestici, i luoghi che dovrebbero proteggere e invece divorano. Ogni spazio è compresso, saturato, senza via di fuga. Persino la luce naturale è filtrata da una specie di smog emotivo. L’ombra del titolo non è una metafora: è la materia oscura e impenetrabile di cui è fatto il mondo del racconto.
La regia di Tsukamoto, da sempre visceralmente fisica, qui si fa paradossalmente naïf, con un minimalismo fortemente memore del neorealismo più spoglio, pur rimanendo fedele a una grammatica del dolore vicina alle teoresi visive di A Snake of June (2002) o Vital (2004). La macchina da presa osserva con uno sguardo decisamente naturale, privo di eccessi manieristici: i movimenti sono misurati, quasi tremanti, come se anche l’occhio del regista appartenesse a un sopravvissuto troppo impaurito o svuotato di emozioni per intervenire. Non c’è più spazio per la frenesia o per le urla metalliche di Tetsuo (1989). In Hokage il ritmo è quello della rimozione, della memoria che riaffiora a strappi. Gli attori si muovono inoltre su un registro contenuto, quasi asfittico; ed è proprio questo controllo iniziale a rendere devastanti le esplosioni emotive che giungono successivamente. Il personaggio di Shuri, in particolare, costruisce una performance articolata nei dettagli: una mano che trema, una voce che si incrina, uno sguardo che evita, fino al climax di infelicità e malinconia che la tiene prigioniera nelle sue stanze. Il soldato reduce e il vagabondo ripercorrono lo stesso sviluppo: nelle vesti di presenze ectoplasmatiche, parlano poco e trattengono le loro emozioni in un continuo vagare senza meta, trasmettendo infine un dolore antico solo al culmine della disperazione. Insieme, questi fantasmi animano una vicenda che non cerca redenzione, ma solo il diritto a un lutto atteso.
Pubblicato il:
Tag:
Consigliati per te
Il regista di Singapore, con il suo ultimo 'Spirit World - La festa delle lanterne', confeziona un storia suggestiva ma forse eccessivamente frettolosa.
Nonostante la prepotente componente visiva, il risultato finale è un’opera che non riesce a soddisfare le aspettative di un film considerabile coinvolgente.
Hurry Up Tomorrow, di Trey Edward Shults, è un film caotico e simbolico che rappresenta il processo creativo ed emotivo dietro l’ultimo album di The Weeknd.