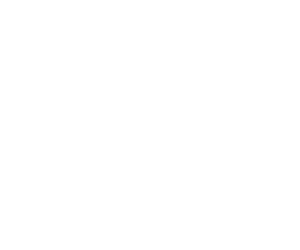Cure di Kiyoshi Kurosawa

Diretto da
Starring
Con Cure, in questi giorni per la prima volta nelle nostre sale, Kiyoshi Kurosawa non solo compie un deciso e decisivo passo in avanti per la sua carriera personale – evolvendo da film di genere, costantemente messi in discussione, quali il pinku eiga di Kandagawa inran sensō (1983) o l’horror più tradizionale di Sweet Home (1989) -, ma si inserisce in una traiettoria filmica che stava prendendo forma nell’intera cinematografia giapponese, anticipando ciò che Ring (Nakata, 1998) avrà il merito di portare sugli schermi occidentali, anche grazie al colossale successo del rivedibile remake hollywoodiano The Ring (Verbinski, 2002): il J-horror, un genere sì definito dalle tematiche orrorifiche di matrice psicologica e da un ricorso sistematico a simboli e motivi della tradizione folkloristica nipponica, ma sostanzialmente indefinibile, sfuggente, e che proprio in questa incertezza ontologica trova il suo perno d’interesse più puro.
Lungi dall’adagiarsi sulle consuete convenzioni narrativo-espositive dell’orrore, spesso figlie di un desiderio spettacolare che collide con le volontà più intime del genere di cui il film è insieme antesignano e massima espressione, Cure si erge come una meditazione profonda e radicale sull’impercettibile e lo sconosciuto, e tramite un’architettura visiva e narrativa che sfida le certezze e scommette sull’irresolutezza diviene spazio inquietante in cui il terrore non esplode in manifestazioni esplicite, ma si insinua subdolamente nella coscienza spettatoriale, generando un disturbo interiore dal quale non è ammessa via d’uscita, men che mai possibilità di risoluzione.
L’incursione insidiosa e individuale nelle singole menti osservanti è possibile grazie a una seducente operazione filmica che si avvale di un utilizzo ingegnoso, audace e poco convenzionale di alcuni tra gli strumenti cinematografici più consueti, convertiti in veicoli di inquietante disorientamento. Anzitutto, la colonna sonora, che non concede alcuna sottolineatura emotiva o drammatica agli eventi messi in scena, ma si configura come accompagnamento evocativo, sussurrato, appena percettibile, accompagnando gli sviluppi senza mai imporsi, come un’ombra sottile e persistente. Allo stesso modo, lo stile registico, costruito su una successione di assorti piani-sequenza, che seguono i personaggi in un flusso ipnotico senza fine, provoca un’efficace disgregazione disagiante, in cui non tanto l’imprevedibilità, quanto il suo esatto opposto, assume il ruolo di protagonista fatale, inevitabile, producendo uno smarrimento diegetico ed esistenziale mai esplicitamente manifestato, ma lentamente accennato, facendo sfumare l’insondabile distinzione tra realtà e finzione, verità e falsità, concreto e metafisico.
In questo impianto struggente, agghiacciante, equilibrato, ma non fintamente costruito, oggetti quotidiani tramutano il loro utilizzo in un’identità inesorabilmente riflessiva, a tratti metacinematografica: porte che divengono cornici, mura ripide che deviano lo sguardo, libri impolverati che si frappongono come ostacoli alla curiosità morbosa e alla brama di conoscenza di personaggi e pubblico, e vetri appannati che evocano l’urgente necessità di un’indagine acuta, profonda, in grado di squarciare il velo di reticenza e avversione presente sia sugli irrisolti omicidi inerenti all’opera cinematografica, sia, soprattutto, sul Giappone contemporaneo, scrutinato da Kurosawa con lucida acribia.
La struttura così ordita consente alla violenza di emergere, manifestarsi in istanti fugaci, sconvolgere nella sua espressione inaspettata e poi svanire, almeno temporaneamente, solo per far nuovamente ritorno, e compiere ancora una volta il suo ciclo, al contempo vitale e mortifero. Emblemi di un’acuta riflessione sull’orrore – inteso come entità generata dalla percezione distorta e frammentata della realtà, costantemente in divenire e in perpetua crisi – la vessazione, l’intolleranza e il conflitto, nell’opera di Kurosawa, altro non sono che una rivelazione implacabile, uno svelamento che ci costringe a scavare nei recessi della psiche umana e a insinuarsi nelle fessure più oscure del nostro universo mentale. E gli squarci di ricordi frammentati, i tagli a X sul corpo delle vittime, le terribili sequenze immaginate, che si materializzano come visioni disturbanti, e i diversi interrogatori al sospettato Mamiya (Masato Hagiwara) condotti dal detective Takabe (Yakusho), processi di auto-riflessione che trascendono il diegetico e sfociano in una vera e propria auto-esplorazione, ne costituiscono uno struggente corrispettivo filmico.
Cure si staglia dunque come un’inesorabile discesa nei meandri più oscuri e inesplorati dell’essere umano, un analemma artistico che si avvolge su sé stesso in un ciclo infinito, destinato a una ricerca senza esito, a un ritorno perpetuo al punto di partenza, senza conclusioni né via di salvezza, che si alimenta del continuo rifiuto della rassicurazione e che affonda le proprie radici nell’incertezza fondante l’umanità e la sua inesplicabile essenza.
Pubblicato il:
Tag:
Consigliati per te
'The End' è un dissonante musical post-apocalittico che unisce ambientalismo e temi sociali con una classica storia d’amore al di fuori del tempo.
'Jurassic World - La rinascita', il nuovo capitolo della saga di Jurassic Park con Scarlett Johansson e Jonathan Bailey alla ricerca di dinosauri geneticamente modificati
Il regista di Singapore, con il suo ultimo 'Spirit World - La festa delle lanterne', confeziona un storia suggestiva ma forse eccessivamente frettolosa.