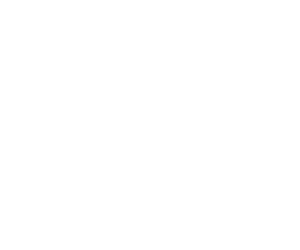La stanza accanto di Pedro Almodóvar

Diretto da
Starring
Sulle caviglie sottili, fragili, ma incrollabili, sul volto pallido, sofferente, elegiaco, ma ancora capace di aggrapparsi alla vita con una tenacia silenziosa e sulle vesti immacolate, ma asettiche, prive della possibilità di trovare un futuro abitabile di Martha (Tilda Swinton) e sull’empatia relazionale, sulla perizia professionale nel confrontarsi con dilemmi esistenziali e sulla disponibilità a mettersi in discussione di Ingrid (Julianne Moore), Pedro Almodóvar edifica con La stanza accanto, Leone d’oro all’ultima Mostra del Cinema di Venezia, un’intima riflessione e un’implacabile analisi sul tempo presente, modellato tramite i suoi stilemi, per segnalare la necessità di un’arte – cinematografica e non solo – in grado di continuare a interrogare e interrogarsi.
Ma almeno sulla (sua) conclusione, Martha è risoluta nel voler mantenere il pieno controllo: «Sopravvivere è deludente» arriverà a confessare. Non l’ennesima dichiarazione, forse abusata, del desiderio di continuare a vivere solo nella misura in cui si possa esistere pienamente, ma una presupposizione che nel contesto contemporaneo diviene significativa, addirittura urgente. Almodóvar, infatti, attraverso un’indagine interstiziale, meticolosa, quasi microscopica, costruisce il ritratto di un presente permeato da opportunità mancate, circostanze sfavorevoli, svolte imprevedibili, il cui contraltare cinematografico trova espressione nella stratificazione culturale del film: le avventure di Buster Keaton, il duplice Gente di Dublino (dal capolavoro letterario di James Joyce al film di John Huston), il rimando delicato a Lettere di una sconosciuta (1948) di Max Ophüls, l’omaggio visivo all’estetica bergmaniana – e a Persona (1966) in particolare, con un primo piano distorto che immortala i volti delle due protagoniste, fragili muse in un mondo decadente. Il film si dispiega dunque in un caleidoscopio di richiami e suggestioni, un universo culturale e sensoriale di tale densità da indurre personaggi e spettatori a un coinvolgimento insieme critico ed emotivo, in cui smarrirsi non è solo possibile, ma quasi inevitabile.
E l’unico modo per eludere questa sovrabbondanza di frammenti e memorie sembra non consistere più nel colmare la verità con la finzione – Martha, reporter di guerra, ha trasfigurato una sua esperienza, poi rimasta inedita; Ingrid, scrittrice, aspira a romanzare la vita della pittrice americana Dora Carrington -, quanto piuttosto nell’acquisire coscienza di sé, nel decifrare quel senso di conclusione che ci attanaglia sin dalla nascita, nel tentare di carpirne il suo significato più profondo.
Alla conclusione del film, però, un flebile raggio di speranza penetra in quell’uggiosa dimora, dove la volontà di morire, ormai plasmata in materia, si è finalmente concretizzata: in una visione al contempo realistica e surreale, appare la figlia di Martha, Michelle, sempre interpretata da Tilda Swinton – La donna che visse due volte? -, che distesa sulle sdraio del balcone sembra inconsciamente riproporre, come sua madre prima di lei, il celebre dipinto Gente al sole di Edward Hopper. È come se solo l’arte, grazie alla sua intrinseca capacità di mediare tra realtà e immaginazione, possa ristabilire un’armonia tra razionalità e sentimento, in un mondo in cui il diritto alla libertà appare oramai svuotato di ogni essenza.
Pubblicato il:
Tag:
Consigliati per te
La lista dei film più attesi del 2026 secondo la redazione di Strade Perdute Magazine
Con 'Hamnet' Zhao trasforma il dolore in poesia viva: Shakespeare custodisce suo figlio nell'Amleto, dove la perdita diventa memoria.
Josh Safdie firma un biopic sportivo elettrico con un Timothée Chalamet totalizzante. "Marty Supreme" non sta mai fermo. Nemmeno quando servirebbe.