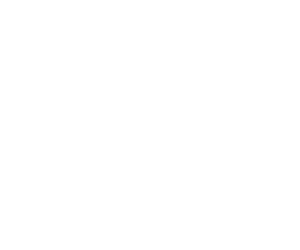La febbre dell’oro di Charlie Chaplin

Diretto da
Starring
Oggi, a cent’anni dall’uscita de La febbre dell’oro (1925), tornare al capolavoro di Charlie Chaplin significa riaffacciarsi su un mondo in cui la tragedia si fa danza e l’umanità si riflette nella figura fragile e misteriosa dell’iconica maschera del regista inglese. Il critico francese André Bazin identificava il personaggio di Charlot come quello di un mito moderno, «un eroe come lo erano per altre civiltà Ulisse»; un’icona capace di dominare ogni avventura. Con i suoi baffetti e la camminata oscillante, simile a quella di un ingenuo pinguino, Charlot esemplificava la goffa eleganza di un eterno vagabondo. Non è un caso che “tutti ridano dapprima dello stesso riso”: il suo gesto parla un linguaggio comune – infantile eppure profondissimo.
Charlot appartiene allo stesso pantheon di Pulcinella, Pantalone, Arlecchino, figure destinate a sopravvivere al proprio tempo, divenute iconografia. La dinamicità di «The Tramp» – una continua improvvisazione che ribalta il senso degli oggetti, dei luoghi, delle convenzioni – ha modellato la comicità cinematografica per generazioni.
In The Gold Rush – titolo originale che richiama la “corsa all’oro” del Klondike – Chaplin racconta la febbrile illusione della ricchezza come condizione esistenziale dell’uomo moderno. L’apertura del film, con la lunga fila di cercatori – piccoli puntini neri immersi nel bianco immenso della neve – è un’immagine che racchiude l’intera critica sociale del cineasta inglese: l’umanità, attratta dalla promessa di un benessere materiale, si riduce a una processione di formiche, confonde la propria individualità, si perde nei futili valori del capitalismo nascente come un topo attratto dall’odore del burro. La povertà e la fame non si riducono però a mere tematiche, ma sono presenze costanti che Chaplin trasforma in gag memorabili e dolorose, come la celeberrima scena della scarpa cucinata e mangiata con dignità da grande gourmet. O ancora, la divertentissima (e insieme straziante) scena attraverso cui la metafora del cannibalismo estremo si concretizza nell’immagine del povero Charlot come un pollo da spennare a grandezza d’uomo, preso di mira dal delirante e affamato Big Jim.
È così che il mondo ostile del Klondike – le montagne, il vento, la neve, le persone – ci appare come un organismo desideroso di schiacciare Charlot. Eppure, come sempre accade nei film di Chaplin, il vagabondo riesce a infiltrarsi tra le crepe del destino, trasformando le sventure in performance, l'imprevisto in invenzione e la tragedia in risata. È un personaggio che subisce la vita e al contempo la domina, oscillando in un equilibrio precario e paradossalmente stabile, proprio come la baracca sospesa sul burrone nel folle finale del film.
Rivedere oggi La febbre dell'oro significa anche riconoscerne l'importanza nella storia personale del suo autore. Chaplin ne realizzò due versioni: l'originale del 1925, uno dei massimi successi dell'era del muto (nonché una delle produzioni più dispendiose), e quella sonorizzata del 1942, da lui stesso voluta per mantenere viva l'opera in un'epoca ormai dominata dal sonoro. Un gesto, insomma, che testimonia quanto il regista considerasse questo film come uno dei vertici più importanti della propria carriera artistica. Il segreto della sua longevità sta proprio nella capacità di Charlot di intercettare la risata del pubblico per poi restituirle un retrogusto amaro, un pensiero che morde. Chi ha avuto la fortuna di vedere Chaplin sul grande schermo sa che la sua comicità non si è affievolita: come diceva Totò, «la comicità è immortale», e in La febbre dell'oro appare più vitale che mai. Chaplin riesce, ancora oggi, a scaldare la nostra immaginazione così come Charlot scaldava la sua piccola baracca nel gelo: con l'ingenuità, la grazia e la disarmante forza di chi sa trasformare la vita in poesia.
Pubblicato il:
Tag:
Consigliati per te
La lista dei film più attesi del 2026 secondo la redazione di Strade Perdute Magazine
Con 'Hamnet' Zhao trasforma il dolore in poesia viva: Shakespeare custodisce suo figlio nell'Amleto, dove la perdita diventa memoria.
Josh Safdie firma un biopic sportivo elettrico con un Timothée Chalamet totalizzante. "Marty Supreme" non sta mai fermo. Nemmeno quando servirebbe.