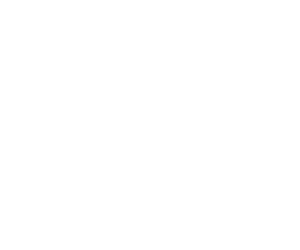Sirāt di Óliver Laxe

Diretto da
Starring
Sirāt è il ponte tra inferno e paradiso, sottile come un capello e affilato come una lama. Ultimo lavoro di Óliver Laxe, vincitore del Premio della Giuria alla 78ª edizione del Festival di Cannes, Sirāt assume questa immagine liminale come chiave simbolica della propria costruzione. Ma più che raccontare un attraversamento, il film sembra interessato a prolungare una condizione di sospensione e logoramento. La premessa narrativa è volutamente semplice: un padre e il figlio adolescente attraversano il deserto alla ricerca di Marina, figlia e sorella scomparsa da cinque mesi, forse unitasi a una comunità rave itinerante. Tutto farebbe pensare a un racconto sul legame familiare, sull’attesa e sulla possibilità del ricongiungimento; invece, la storia devia rapidamente da questa traiettoria, svuotando il viaggio di una direzione riconoscibile e rinunciando progressivamente a qualsiasi forma di sviluppo narrativo tradizionale.
Girato in 16 mm e immerso in una palette di colori caldi e terrosi, il film rende il deserto quasi tangibile: il caldo opprimente, la sabbia che invade lo spazio, i corpi affaticati e sudati. Laxe costruisce un road movie immobile, in cui lo spostamento non produce avanzamento, ma reiterazione. I personaggi restano figure opache, prive di un vero arco di trasformazione: non vengono approfonditi psicologicamente, né messi in relazione tematica con ciò che accade loro. In questo contesto, l’uso della musica EDM assume un ruolo centrale e singolare: non semplice commento sonoro, ma dispositivo percettivo che altera il tempo del film, avvicinandolo alla dimensione trance per cui la cultura rave è spesso vissuta come pratica rituale e spirituale, una momentanea dissoluzione dell’identità. Sirāt sembra interrogarsi, almeno in superficie, su cosa accada quando questa perdita del sé smette di essere simbolica.
È sul piano politico che il racconto mostra le sue ambiguità più problematiche. «A sud, vicino alla Mauritania» è una delle pochissime coordinate spaziali concesse, e la scelta non è neutra. Il Marocco confina con la Mauritania solo se si assume come naturale l’occupazione marocchina del Sahara Occidentale, territorio mai decolonizzato. Il deserto non viene mai nominato, ma è chiaramente riconoscibile come Nord Africa, trasformato però in uno spazio astratto, silenzioso, funzionale a una messa in scena più estetizzante che interrogativa. Si parla genericamente di “deserto”, come se fosse uno spazio irreale, quando invece è una terra concreta, ferita, storicamente violentata. La presenza dei raver europei, francesi e spagnoli, richiama inevitabilmente un retaggio coloniale che il film non approfondisce, ma che grava sulla lettura dell’opera. Il loro viaggio è tempo libero, evasione pura. Quando elementi del contesto geopolitico provano a emergere – civili in movimento, notizie radiofoniche deliberatamente spente, segnali di un conflitto imminente – non c’è mai un vero confronto con la realtà. Bisogna solo arrivare al prossimo rave. La narrazione sembra suggerire che l’angoscioso destino di questi personaggi non derivi da una tragica inconsapevolezza, ma da un’ignoranza attiva. Ed è qui che Sirāt scivola in una moralità punitiva: i festaioli occidentali vengono schiacciati dal contesto che hanno scelto di ignorare.
Nella sua seconda metà, il film accentua la propria deriva verso una dimensione simbolica e allucinata, accumulando tensione e spaesamento fino a erodere qualsiasi possibile identificazione o riflessione articolata. La pellicola sembra interessata più a destabilizzare che a costruire un senso, affidandosi a un crescendo di shock e a un’atmosfera di fine imminente – «è questo che si prova quando finisce il mondo?» – che resta però più evocata che realmente elaborata. Il finale, coerentemente, rifiuta qualsiasi forma di chiusura o consolazione, lasciando lo spettatore immerso nell’incertezza. Sirāt si impone così come un’opera visivamente potente e percettivamente estenuante, capace di incidere sui sensi ma meno efficace nel trasformare quell’impatto in un discorso critico che vada oltre l’esperienza. È un ponte che promette attraversamento, ma che alla fine spinge lo spettatore a sostare in bilico, sospeso tra fascino visivo e smarrimento emotivo.
Pubblicato il:
Tag:
Consigliati per te
Come i biopic fungono da memorabilia per riportare in vita i fantasmi dei personaggi storici, musicali e sportivi del passato.
Ne "Il filo del ricatto – Dead Man’s Wire" di Gus Van Sant, il filo non è solo congegno meccanico, ma il dispositivo che tiene insieme sofferenza privata e spettacolo mediatico.
Dentro 'La gioia': racconto della presentazione alla Scuola Holden.