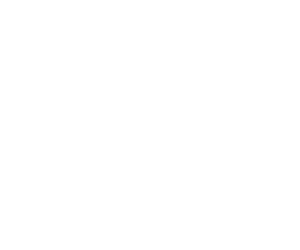Grand Tour di Miguel Gomes

Diretto da
Starring
Essere catapultati nella dimensione visiva, fisica e temporale di Grand Tour (2024) può disorientare. Può un film essere contemporaneamente un’avventura picaresca in costume e un documentario di viaggio? «Deve» risponderebbe Miguel Gomes. E perché? «Perché può» rincalzerebbe. Gomes è uno dei pochi registi che crede ancora ciecamente nella capacità miracolosa del cinema di unire materiali distanti tra loro. Risiede proprio nella sintesi quindi il lavoro del cineasta portoghese, il quale nella sua ultima opera, fonde insieme (almeno) due film. Due grand tour asiatici, uno coloniale e uno post-coloniale. Nel primo, ambientato nel 1918, è narrata la fuga del funzionario britannico Edward (Gonçalo Waddington), inseguito dalla sua promessa sposa Molly (Crista Alfaiate) per suggellare, con il matrimonio, un fidanzamento durato sette anni. Il secondo, collocato nel nostro presente, prende invece la forma di un travelogue attraverso le medesime nazioni asiatiche: Birmania, Singapore, Vietnam, Filippine, Giappone e Cina. Più delle singole storie è la sintesi tra le due, appunto Grand Tour, ad affascinare e ipnotizzare lo spettatore. Una sorprendente crasi tra il mondo antico e quello moderno che svela inattese affinità. Un accostamento che sprigiona un interscambio entropico di emozioni. Capita quindi di commuoversi per l’interpretazione sofferta di My way di Sinatra da parte di uno sconosciuto in un karaoke bar, come di ridere spernacchiando, insieme a Molly, di fronte alle sventure che continuano ad abbattersi su di lei. Un’irradiazione reciproca che intacca lo statuto stesso dei materiali audiovisivi. I puri sentimenti tragici dell’inseguimento ai confini del mondo alimentato dall’amor fou di Molly si riversano nelle immagini di un’Asia contemporanea indaffarata e caotica; viceversa la concretezza e la semplicità della quotidianità dei filmati documentari incorniciano ironicamente la storia di Edward e Molly, ricontestualizzandola e demitizzandola.
«La mano è rozza, ma l’animo sensibile» veniva detto in Tabu (Miguel Gomes, 2012). Lo stesso si potrebbe dire di Miguel Gomes. Non per descrivere uno stile antiestetico, ma, al contrario, per esaltare la semplicità degli strumenti scelti. Ne sono un esempio i mascherini (presi direttamente dal cinema muto) utilizzati per circoscrivere volti e dettagli, gli ironici «bip» di censura e soprattutto la capacità, tramite il montaggio, di creare mondi ulteriori semplicemente sovrapponendoli. Come in una transizione infinita, spesso passato o presente – per noi, per i protagonisti invece presente e futuro – sono difficilmente distingubili. Si genera così un terzo film, nella quale le gesta di Edward e Molly, narrate in voice over, si materializzano nelle folle della metropoli, dando voce a echi lontani di un passato ancora presente. È dunque spiegato il motivo per cui, nel suo Le mille e una notte – Arabian Nights (2015), Gomes affermava «l’astrazione mi dà le vertigini». Non c’è niente di più materico e artigianale di usare il linguaggio cinematografico per dominare lo spazio e il tempo.
Pubblicato il:
Tag:
Consigliati per te
'The End' è un dissonante musical post-apocalittico che unisce ambientalismo e temi sociali con una classica storia d’amore al di fuori del tempo.
'Jurassic World - La rinascita', il nuovo capitolo della saga di Jurassic Park con Scarlett Johansson e Jonathan Bailey alla ricerca di dinosauri geneticamente modificati
Il regista di Singapore, con il suo ultimo 'Spirit World - La festa delle lanterne', confeziona un storia suggestiva ma forse eccessivamente frettolosa.