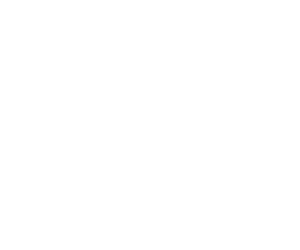In un’epoca in cui il cinema fatica a riaffermare la propria centralità culturale all’interno di un complesso ecosistema mediale, i premi cinematografici hanno smesso di essere mera consacrazione estetica e sono divenuti atti deliberati, al limite della dichiarazione politica. Ebbene, nell’Ottantaduesima edizione della Mostra del Cinema di Venezia, suddetta tensione è emersa limpidamente. Non solo per il Leone d’Oro – al centro di diverse controversie che verranno approfondite in seguito -, ma per le scelte che costituiscono l’assetto dell’intero palmarés. La distribuzione dei premi ha di fatto confermato una tendenza ormai consolidata: la sostituzione del rischio con la rassicurazione, dell’audacia con la gestione, dell’innovazione con il consenso prevedibile. Nel gioco sottile di equilibri e discontinuità che da sempre definisce l’identità dei grandi festival internazionali, Venezia82 ha mostrato quanto fragile possa essere oggi la linea di confine tra la celebrazione del talento e la conservazione di un sistema che, forse, non sa, o non vuole, più (farsi) sorprendere.
Si può partire da uno dei paradossi più evidenti: quello del Premio Marcello Mastroianni, pensato – almeno teoricamente – per valorizzare attori e attrici emergenti, se non fosse che il riconoscimento sia andato a una delle co-protagoniste di Silent Friend, nonostante questa vanti una carriera cinematografica ben avviata, con all’attivo, tra le altre, una parte in Storia di mia moglie (2021), il precedente film della stessa Ildikó Enyedi. Etichettarla come “nuova promessa” appare, dunque, quantomeno discutibile. Una costruzione narrativa arbitraria, forse funzionale a legittimare una decisione presa secondo logiche che poco hanno a che fare con la valorizzazione del talento emergente e molto più con l’equilibrio delle rappresentanze e la gestione del consenso critico.
Tra i riconoscimenti più attesi, la Coppa Volpi per le migliori interpretazioni: quella maschile è stata assegnata a Toni Servillo per aver dato corpo e voce al Presidente della Repubblica Mariano De Santis in La Grazia – una scelta che conferma l’affidabilità di un interprete la cui maestria sembra ormai al di là di ogni valutazione. Tuttavia, proprio la prevedibilità del premio solleva un dubbio su un ipotetico riconoscimento a Dwayne Johnson per la sua interpretazione in The Smashing Machine, capace di fondere fisicità e vulnerabilità con sorprendente coerenza, e che avrebbe potuto incarnare una stimolante forma di audacia interpretativa e produttiva. Sul versante femminile, la vittoria di Xin Zhilei per The Sun Rises on Us All assume invece un valore quasi opposto. Qui non c’è l’aderenza a un nome consolidato, ma l’esplosione di una presenza scenica che ridefinisce il film stesso. In un’opera nel complesso fragile, dispersiva e sbilanciata, la sua interpretazione agisce come centro gravitazionale, imponendo una tensione emotiva che il testo narrativo non riesce a sostenere in autonomia. È una performance che trascende il dispositivo filmico, lo eccede, e che proprio per questo avrebbe meritato maggiore attenzione nel discorso critico post-festival, troppo spesso orientato verso dinamiche di visibilità già consolidate.
Altri casi rivelatori risultano essere il Premio Speciale della Giuria, assegnato a Gianfranco Rosi per Sotto le nuvole, e quello per la miglior sceneggiatura, andato a Valérie Donzelli e Gilles Marchand per À pied d’œuvre. Due riconoscimenti assegnati a film indubbiamente solidi, eleganti, ma ben lontani dall’essere memorabili. Nel caso di Rosi, soprattutto, il premio sembra più un (ennesimo) atto di legittimazione che una reale valorizzazione della sua ultima opera. La sensazione che emerge, ancora una volta, è quella di una giuria che ha scelto la strada più rassicurante: riconoscere l’autorevolezza, piuttosto che il rischio. In questa prospettiva, appare ancor più significativa l’assenza di riconoscimenti per Un film fatto per bene di Franco Maresco e A House of Dynamite di Kathryn Bigelow. Il primo – pur considerando che Maresco aveva già ottenuto il Premio Speciale della Giuria per La mafia non è più quella di una volta (2019) – rappresentava un candidato naturale a tal riconoscimento: dissacrante, corrosivo, spiazzante, politicamente impresentabile ed esteticamente densissimo, Un film fatto per bene è un’opera che non cerca consenso, ma lo mette in crisi, costringendo a una presa di posizione. E ignorarlo equivale a silenziare una voce necessaria, scomoda proprio perché libera, in nome di un equilibrio che riflette un atteggiamento prudente, più che reale confronto critico. Parimenti inspiegabile è l’assenza del premio alla miglior sceneggiatura per A House of Dynamite: la scrittura di Kathryn Bigelow – tagliente, solida, rigorosamente strutturata – rappresenta uno dei vertici della Mostra: un esempio di lucidità tematica e formale, capace di affrontare questioni urgenti con intelligenza narrativa e tensione morale. La sua mancata premiazione appare come un segnale di chiusura nei confronti di un cinema in grado di miscelare brillantemente complessità politica e forza espressiva.
Il quadro che emerge dal palmarès ora presentato è quello di un festival che ha privilegiato la prudenza, la conferma, scegliendo di affidarsi a nomi consolidati piuttosto che valorizzare ciò che di realmente originale e necessario è emerso. Questa tendenza ha trovato il suo culmine nell’assegnazione del Leone d’Oro a Father, Mother, Sister, Brother di Jim Jarmusch, a scapito del ben più acclamato The Voice of Indira Rajab di Kaouther Ben Hania. Scelta che ha rappresentato una straordinaria occasione mancata, oltre che la decisione più controversa dell’intera Mostra.
Facciamo un piccolo passo indietro. Già nei giorni precedenti alla cerimonia di chiusura, The Voice of Indira Rajab era considerato da stampa e pubblico il favorito per la vittoria del premio principale. Non esclusivamente per la sua indiscutibile qualità cinematografica, ma per l’urgenza della tematica affrontata: un episodio della guerra in Palestina, raccontato con uno sguardo personale, asciutto, distante da qualsiasi retorica e impossibile da ignorare. All’interno dell’ambiente festivaliero, si respirava un consenso pressoché unanime: più che una previsione, quella della vittoria appariva come una logica conseguenza.
Poche ore prima dell’inizio della cerimonia di premiazione, però, sono emerse indiscrezioni circa una spaccatura significativa all’interno della giuria presieduta dal regista statunitense Alexander Payne, in particolare su un presunto dissenso espresso dall’attrice Fernanda Torres. Alcuni resoconti – presto smentiti – hanno persino ipotizzato un suo abbandono anticipato del Lido in segno di protesta, con un rientro in Brasile prima della chiusura del festival. Lo stesso Payne ha poi ridimensionato la vicenda: «Nessuno ha minacciato nulla. Viviamo in un mondo in cui sappiamo di non dover credere a tutto quello che leggiamo su Internet» ha asserito il regista. Al di là della veridicità di queste ricostruzioni, ciò che resta è la sensazione chiara di una scelta di equilibrio, un compromesso, un punto d’incontro, più che una decisione convinta.
Per queste motivazioni il mancato riconoscimento ha scatenato un virale dibattito mediatico. E in un’epoca segnata da fratture profonde e crisi rappresentative, mentre il conflitto israelo-palestinese continua a interrogare le coscienze e a dividere l’opinione pubblica globale, premiare un film capace di affrontare quella realtà con rigore, intelligenza e sensibilità avrebbe rappresentato un gesto di alta responsabilità culturale. Non si tratta, naturalmente, di ridurre il cinema a strumento ideologico, ma di riconoscere consapevolmente che il valore di un premio risiede anche nella sua capacità di dare spazio a ciò che ancora fatica a emergere, legittimare sguardi nuovi e discorsi necessari. Non solo rappresentare il presente, quindi, ma misurarsi con la sua complessità. La Mostra ha scelto la continuità. Eppure, l’arte cinematografica che lascia traccia – quello che scava, che disloca, che apre varchi – risiede in quella zona incerta e irrisolta, aspra e non conciliata, dove la visione si espone, vivendo nella sua verità più radicale.
Pubblicato il:
Tag:
Consigliati per te
Sirāt si impone come un’opera visivamente potente e capace di incidere sui sensi, ma fatica a tradurre tale impatto in un solido discorso critico.
Park Chan-wook torna a meravigliarci con le divertenti e violente assurdità di 'No Other Choice'.
Strade Perdute esce con un nuovo numero sei dal tema Viaggi!